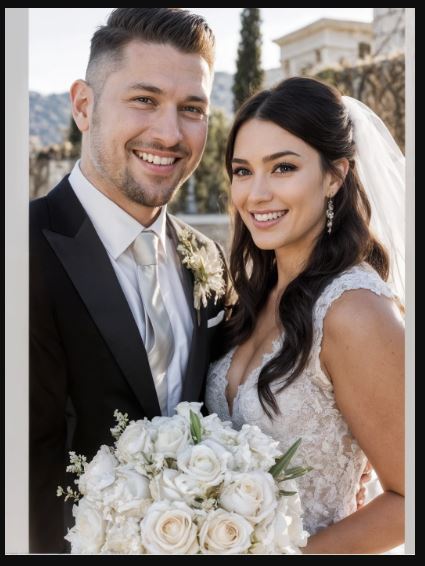Sono rientrata dal lavoro con largo anticipo, stremata e con addosso ancora l’odore dell’ufficio. Appena ho infilato la chiave nella serratura, però, ho capito che qualcosa non combaciava: Grisha era lì, sulla soglia, già pronto ad accogliermi. E sul suo volto brillava un sorriso insolito, troppo pieno, quasi studiato.
«Amore… giornata pesante?» mi chiese, baciandomi la guancia con una dolcezza che non vedevo da tempo.
«Terribile,» sospirai, buttando la borsa sul tavolino. «Volevo solo togliermi le scarpe e sparire.»
Lui batté le mani, come se fosse la soluzione a tutto. «Allora vieni. Siediti. Ti faccio un massaggio ai piedi.»
Mi bloccai. Grisha? Un massaggio ai piedi? L’uomo che sbuffava persino quando gli chiedevo di passarmi il telecomando? Avrei voluto credere al miracolo, a un momento di tenerezza tardiva… ma la mia pancia si strinse in quel modo preciso che avevo imparato a riconoscere: la sensazione che stai per scoprire qualcosa che non vuoi sapere.
«Sul serio?» dissi, alzando un sopracciglio.
«Sul serissimo.» Mi guidò verso il divano con un’attenzione quasi solenne. «Te lo meriti.»
La stanchezza vinse la diffidenza. Mi lasciai sfilare le scarpe e appoggiai i piedi. Le sue mani erano sorprendentemente delicate, ma il resto di lui no: era teso. Ogni tanto lanciava uno sguardo rapido verso il corridoio, come se stesse controllando un timer invisibile. Parlava troppo, rideva troppo forte, riempiva il silenzio di frasi inutili, come se il silenzio gli facesse paura.
«È… piacevole,» ammisi, ma più lo dicevo e meno ci credevo.
Lui ridacchiò. «Non posso viziare mia moglie senza essere interrogato?»
Stavo per rispondere quando un suono secco tagliò l’aria: uno scatto leggero, come un gancio che si muove, come una maniglia sfiorata male. Proveniva dal bagno.
Mi irrigidii di colpo. «Hai sentito?»
Grisha si fermò per un istante, giusto il tempo di tradirsi. Poi ripartì con una risata nervosa. «I tubi. Sai com’è… questa casa è vecchia.»
Vecchia o no, quello non era un tubo. Era un rumore umano.
«Grisha,» dissi piano, «che sta succedendo?»
«Niente!» La sua voce salì di mezzo tono, troppo acuta. «Sei solo stanca. Rilassati…» E le sue dita ripresero a massaggiare, più veloci, quasi a inchiodarmi lì.
Mi alzai lo stesso.
«Aspetta!» scattò lui, in piedi dietro di me. «Dove vai?»
Non risposi. Il corridoio mi sembrò più lungo del solito, come se ogni passo risuonasse contro le pareti. Sentivo il cuore nei timpani, e una parte di me pregava di essersi sbagliata. Ma la parte più lucida, quella che non accetta favole, mi spingeva avanti.
Aprii la porta del bagno.
Mi investì un’aria calda e umida, come se qualcuno fosse appena stato lì dentro. Lo specchio era appannato, il termosifone bollente, e sul ripiano—tra i miei prodotti ordinati—c’era un dettaglio che era un pugno nello stomaco: un rossetto cremisi, nuovo, non mio.
Lo presi in mano e mi voltai. Grisha era sulla soglia, pallido, con lo sguardo che cercava una via d’uscita.
«Questo cos’è?» chiesi, mostrando il tubetto.
Aprì la bocca, ma non uscì nulla di sensato. Solo un fiato spezzato.
E allora l’ho fatto. Ho aperto l’anta dell’armadio a muro, quella dove tenevamo asciugamani e scatole.
Lì dentro, rannicchiata come un animale braccato, c’era una donna. Stringeva un paio di décolleté dal tacco alto tra le braccia, i capelli scompigliati, il viso arrossato. E addosso aveva un accappatoio di seta.
Il mio.
Per un secondo il mondo si svuotò. Non sentivo più il mio respiro, solo un ronzio incessante. Poi la rabbia arrivò, netta, precisa, come se qualcuno avesse acceso la luce.
«Chi sei?» domandai, con una voce che non riconoscevo: ferma, dura.
Lei si tirò su lentamente, cercando di sistemarsi l’accappatoio come se quel gesto potesse renderla più presentabile. «Non è come sembra…» mormorò, già sapendo che era la frase più inutile del dizionario.
Grisha entrò nel bagno con le mani alzate, come se stesse tentando di calmare una bomba. «Tesoro, ti prego. Lasciami spiegare.»
Mi voltai verso di lui, e la mia calma divenne tagliente. «Spiegare cosa? Che c’è una sconosciuta nascosta nel nostro armadio con le mie cose addosso? Che mi fai un massaggio ai piedi mentre lei aspetta là dentro?»
La donna lo fissò con occhi grandi, pieni di panico. «Mi avevi detto che lei non sarebbe rientrata…»
E quella frase fece più male di tutto. Perché non parlava di un errore. Parlava di un piano.
Alzai il rossetto come fosse una prova in tribunale. «Complimenti, Grisha. Hai organizzato tutto.»
Lui fece un passo verso di me. «Era solo… un momento di debolezza.»
«No.» Scossi la testa. «Il massaggio era la debolezza. Il resto è scelta.»
Indicai la porta, senza urlare. Non ce n’era bisogno. «Prendetevi. E uscite. Adesso.»
«Dai, per favore—» iniziò lui.
«Non chiamarmi “per favore”.» La mia voce tremò appena, ma non mi concessi lacrime. «Non hai più diritto a chiedermi niente.»
La donna afferrò le scarpe, scivolò fuori dal bagno come un’ombra e sparì lungo il corridoio. Grisha rimase un secondo immobile, come se stesse decidendo se tentare l’ultima manipolazione. Poi incontrò il mio sguardo e capì che non c’era più spazio per lui.
Uscì anche lui.
E io rimasi lì, in piedi, con il rossetto in mano, lo specchio appannato davanti, e una verità che non potevo più ignorare: non era solo un tradimento. Era una vita intera in cui mi ero abituata a chiedere poco, a giustificare troppo, a farmi andare bene mezze attenzioni e silenzi lunghi.
Quella sera non mi sono spezzata. Mi sono spostata.
Ho preso una scatola dal ripostiglio e ho iniziato a raccogliere le sue cose con una lucidità che mi ha sorpreso: camicie, prodotti da barba, caricabatterie, la sua tazza preferita. Ogni oggetto era un ricordo, ma io non volevo più essere la custode dei ricordi di chi mi aveva mentito.
Quando la scatola era piena, ho chiamato mio fratello.
«Puoi venire?» gli ho chiesto.
«Arrivo. Che succede?»
Ho deglutito. «Grisha non vive più qui.»
Non ha fatto domande. È arrivato in trenta minuti, mi ha abbracciata forte e mi ha aiutata a portare tutto vicino alla porta. Il suo silenzio era un sostegno: niente prediche, niente sollievo esibito. Solo presenza.
Quando Grisha tornò la sera dopo, era pronto a recitare di nuovo. Occhi lucidi, voce bassa, l’aria di chi spera in un perdono a buon mercato.
«Possiamo parlare?» disse.
Gli indicai il mucchio delle sue cose. «No. Puoi solo prenderle.»
«Ti prego, ascolta—»
«Ho ascoltato abbastanza per anni,» risposi, senza alzare la voce. «Adesso tocca a me.»
Restò fermo, come se aspettasse che mi sciogliessi. Poi capì che non sarebbe successo. Raccolse le sue cose e se ne andò, finalmente senza spettacolo.
Il giorno dopo ho avviato le pratiche di divorzio. È stato strano, come firmare un foglio che taglia il filo a un passato intero. Ma sotto quella stranezza c’era una sensazione nuova: leggerezza.
Nei mesi successivi ho ripreso spazio, lentamente. Ho cambiato alcune cose in casa, non per cancellare lui, ma per riscrivere me: ho spostato i mobili, buttato via quello che mi stringeva lo stomaco, riempito le stanze di suoni e persone che mi facevano bene. Ci sono state notti vuote, giornate in cui la rabbia tornava all’improvviso, e momenti in cui mi sembrava di inciampare nei ricordi come in spigoli nascosti.
Ma ogni volta mi rialzavo più in fretta.
Una sera, seduta sul divano del mio soggiorno, ho guardato intorno a me e ho capito una cosa semplice e gigantesca: ero di nuovo a casa. Non solo nella mia casa—nella mia vita.
Il tradimento di Grisha mi aveva ferita, sì. Però mi aveva anche svegliata. Avevo passato troppo tempo a difendere un matrimonio che mi chiedeva di essere piccola, paziente, comprensiva… mentre lui si prendeva il lusso di non esserlo mai.
Ora non lo facevo più.
Ho chiuso quella porta senza nostalgia. E, per la prima volta dopo anni, ho guardato il futuro non con paura, ma con rispetto. Per me stessa.